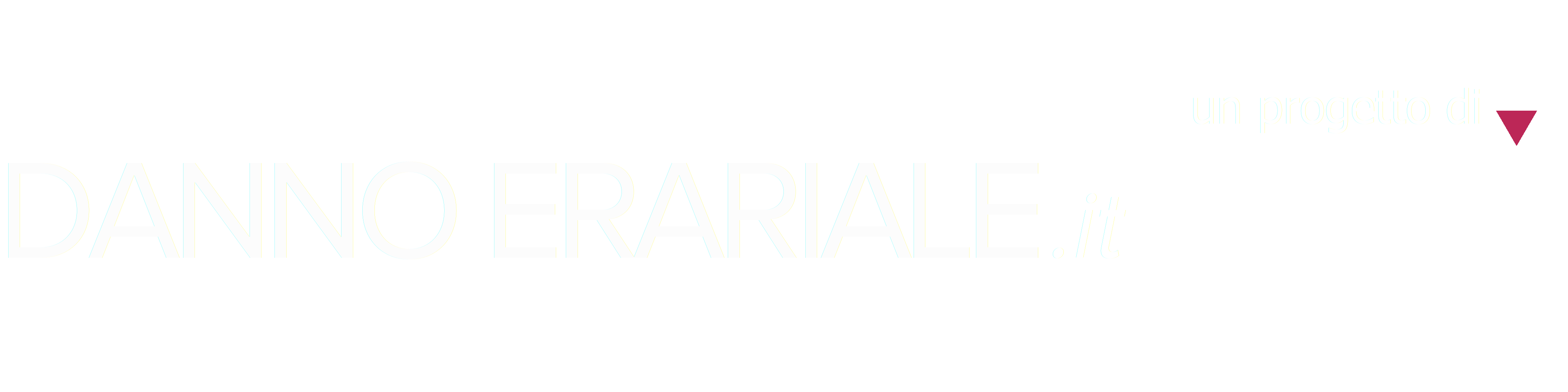In generale
La Corte dei conti ha il potere di quantificare il danno d’ufficio, anche discostandosi dalle richieste delle parti.
Trattandosi di attività della P.A., la commissione del fatto dannoso spesso coinvolge più persone. In questi casi la Corte dei conti, valutate le singole responsabilità, «condanna ciascuno per la parte che vi ha preso»1 (criterio, cosiddetto, dell’apporto causale).
In un’ottica difensiva è sempre fondamentale contestare sia l’an che il quantum del danno, essendo invece frequente la tecnica difensiva del c.d. “scaricabarile”; basata sul difetto di apporto causale del singolo convenuto, in quanto tale tecnica implicitamente ammette il danno e la sua quantificazione.
La rilevanza dei vantaggi conseguiti dall’Amministrazione
Nel giudizio di responsabilità deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’amministrazione di appartenenza, o da altra amministrazione, o dalla comunità amministrata in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità2.
Si tratta di una particolare applicazione, nella materia giuscontabile, dell’istituto civilistico della cosiddetta compensazione del lucro con il danno (compensatio lucri cum damno).
Secondo la giurisprudenza della Corte dei conti, l’applicazione di tale istituto esige che il convenuto provi:
- l’effettività del vantaggio (utilitas) conseguito dalla pubblica amministrazione;
- l’identità causale tra il fatto produttivo di danno e quello produttivo del vantaggio;
- la corrispondenza di quest’ultimo ai fini istituzionali dell’amministrazione che se ne appropria.
Alcune rilevanti differenze, rispetto al giudizio civile, sono costituite dal fatto:
- che la compensatio in materia contabile non costituisce un’eccezione in senso stretto e pertanto può anche essere rilevata d’ufficio dalla Corte o sollevata in appello;
- che il lucro oggetto di compensazione può anche essere stato conseguito da altra amministrazione pubblica o persino dalla comunità amministrata nel suo complesso e quindi da soggetti diversi rispetto a quello danneggiato.
Esempi
- Si è affermato che la compensatio possa trovare applicazione solo quando danno e vantaggio siano conseguenze immediate
e dirette della stessa condotta, siccome causalmente idonea a produrre entrambi gli effetti. Nello specifico, è stato escluso in capo all’appellante, ex primario, in capo al quale era stata accertata una occulta, illecita e, comunque, non autorizzata, né autorizzabile perché incompatibile col regime di esclusività della prestazione, attività di refertazione extraistituzionale di esami radiologici per conto di quattro cliniche sanitarie private, accreditate con il Ssn, fosse riconoscibile la prospettata utilitas in relazione all’asserito raggiungimento degli obiettivi aziendali e nella massima produttività del suo reparto, né che fossero integrati i presupposti innanzi indicati dalla giurisprudenza per dar luogo all’invocata compensatio (sent. n. 354/2023, Sez. II). - In una fattispecie concernente il danno conseguente alla corresponsione di somme ad un dipendente a titolo di mansioni superiori, pur riconoscendosi che la condotta addebitata abbia prodotto un pregiudizio economico certo all’erario, con riferimento ai compensi erogati contra legem, la sezione ha tenuto conto delle attività effettivamente svolte dal dipendente incaricato, comunque dotato dei titoli di studio previsti per la nomina in contestazione (diploma di laurea), producendo così un’utilità per l’ente, che ha reputato congruo individuare nella misura del 50% rispetto all’originario importo individuato dalla stessa procura nell’atto di citazione (sent. n. 473/2023, Sez. I).
La quantificazione del danno all’immagine della Pubblica amministrazione
Nel giudizio di responsabilità, l’entità del danno all’immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.
Il potere riduttivo
Il potere riduttivo è un potere discrezionale della Corte dei conti, in base al quale la Corte che abbia ritenuto accertato un danno, può ridurne l’importo oggetto di condanna a carico del convenuto3, senza addebitarlo ad altri e lasciandolo, pertanto, a carico della collettività.
Si tratta di un potere esercitabile d’ufficio, che però è sempre bene invocare nei giudizi.
Esso va distinto dal caso di riduzione del danno a carico del convenuto per omessa citazione a giudizio, da parte del PM contabile, di altri corresponsabili, perché in questo caso la riduzione costituisce espressione del principio dell’apporto causale.
Secondo la giurisprudenza, il potere riduttivo può essere esercitato solo a fronte di una condotta gravemente colposa, mentre invece resta escluso in caso di illeciti dolosi. L’istituto ha, infatti, l’obiettivo di ridurre il danno da imputare al responsabile in presenza di condizioni, oggettive o soggettive che, ad avviso del giudice, consentano che una quota di esso resti non risarcita, il che collide col particolare disvalore della condotta dolosa (sent. n. 309/2023, Sez. I; sent. nn. 32/2023, Sez. II).
La giurisprudenza ritiene, inoltre, che il giudice contabile abbia l’obbligo di motivazione l’effettivo esercizio del potere riduttivo e non il suo diniego.
Esempi
- L’esistenza di vantaggi personali in capo al convenuto e posti a carico della amministrazione pubblica danneggiata, unitamente alla reiterazione delle condotte illecite, sono stati elementi sufficienti ad escluderne l’esercizio (sent. nn. 315 e 344/2023, Sez. III).
- È stato altresì puntualizzato che la riduzione del danno erariale disposta in primo grado basata sul ruolo degli organi regionali preposti alla vigilanza, costituisce tecnicamente non già esercizio del potere riduttivo ma rideterminazione del danno sotto il profilo di un elemento causale, che ha inciso nel determinismo del pregiudizio erariale ex art. 83, c. 2, c.g.c. (sent. n. 276/2023, Sez. II).